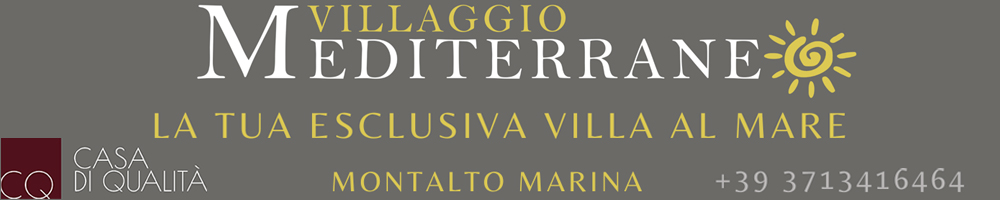L'era del Coronavirus - Intervista al professore di diritto costituzionale Gaetano Azzariti: “I decreti a firma del presidente del consiglio sono atti autoritativi del governo, prima erano giustificati dall’assoluta emergenza, ora non più”
Gaetano Azzariti: “Limitare la libertà attraverso i dpcm è al limite della costituzione”
Viterbo – In bilico tra libertà e restrizioni, tra riaperture e lockdown, il 2020 passerà alla storia come l’anno del Coronavirus. Una pandemia che ha colpito il mondo intero, lasciando dietro di sé morti, insicurezze e nuove abitudini.
Con un ciclo di interviste, Tusciaweb propone un’istantanea di ciò che è stato e ciò che sarà, attraverso le parole e gli occhi di grandi personaggi pubblici.
Gaetano Azzariti
Gaetano Azzariti è professore ordinario di Diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell’università degli studi di Roma La Sapienza. Nel 1981 si laurea, con lode. Tre anni dopo vince il concorso di ricercatore universitario, nel 1990 il concorso di prima fascia. Durante la sua carriera insegna presso le università degli studi di Perugia, Torino, Napoli, e Luiss ed è titolare di corsi di Diritto costituzionale, Istituzioni di diritto pubblico, Diritto regionale, Dottrina dello Stato e Diritto ed economia delle fonti di energia. Per il triennio 2009/2012 fa parte del consiglio direttivo dell’Associazione italiana dei costituzionalisti. È direttore delle riviste Politica del Diritto e Costituzionalismo.it. Fa inoltre parte del comitato di direzione della Rivista di Diritto Costituzionale, del comitato direttivo di Diritto Pubblico, del comitato scientifico di Giurisprudenza Costituzionale e del comitato scientifico della Rassegna di Diritto Pubblico Europeo.
Azzariti, come ha vissuto il lockdown di marzo e le restrizioni regionali successive? Ha avuto esperienze dirette col Covid?
“Il lockdown di marzo è stato un trauma. Per me come per il resto degli italiani, credo. Un fatto del tutto inimmaginabile: nessuno poteva pensare a una pandemia di questo tipo, né che saremmo stati costretti improvvisamente a rinunciare alla nostra quotidianità. Anche chi ha maggiore dimestichezza con la storia e le epidemie del passato, non credo che vedesse e contemplasse, all’interno dell’orizzonte del possibile, quello che è accaduto. Siamo stati scioccati. Nella prima fase si sperava che fosse una parentesi, oggi è più difficile immaginarla come tale. Per fortuna non ho avuto contatti diretti con il Covid: né io né i miei strettissimi famigliari. Durante la prima ondata, non fosse altro perché io abito a Roma e i contagi hanno colpito soprattutto le regioni del nord, ho avuto una percezione più lontana del virus. Nella seconda e terza ondata di gennaio, il cerchio attorno a me si è stretto: ho visto e vedo quasi ogni giorno persone vicine che si contagiano. Questo mi fa percepire in modo molto diretto la drammaticità della situazione”.
Con la pandemia è nata una nuova ed inedita normalità?
“Siamo costretti per necessità a vivere indossando una mascherina e a mantenere una distanza con le persone che ci stanno attorno. Anche quelle più care. Quello che auspico per il futuro, però, è che questo distanziamento sociale non diventi un distanziamento culturale. Una paura nei confronti dell’altro, dettata dalla convinzione che chiunque ci passi vicino possa essere un untore, un contaminatore”.
Farà il vaccino?
“Senz’altro. Appena possibile lo farò”.
Cosa pensa delle teorie complottiste o negazioniste? Ha mai avuto tentazioni negazioniste?
“Penso che siano teorie antiscientifiche e quindi non le prendo nemmeno in considerazione. Posso capire come il Covid, essendo un fenomeno del tutto nuovo, imponga di affidarsi alla scienza e che sia possibile un margine di incertezza. Ma questo non giustifica tali posizioni né incide, ad esempio, sulla decisione di vaccinarsi o meno. Perché farsi il vaccino non è solo una scelta individuale, ha anche una valenza sociale. Abbiamo la necessità a livello comunitario di fermare e frenare questo flagello. La costituzione parla chiaro: il diritto alla salute è un diritto fondamentale di un individuo, ma anche interesse della collettività”.
Come ha trascorso il Natale?
“Chiuso in casa. È stato un Natale anomalo, non uno dei migliori, ma l’ho trascorso con i miei affetti più cari. Per fortuna con me c’erano i miei figli e mia moglie”.
Come giudica l’azione del governo Conte? E Salvini, Meloni e Berlusconi?
“Vorrei astenermi dal dare voti. Credo che ci siano talmente tanti interessi in gioco, che non avrebbe molto senso dare un giudizio assoluto. Conte ha fatto bene o ha fatto male? Sono convinto che poteva fare meglio, ma non ha fatto il peggio. Quello che trovo assurdo è che in una situazione di questo tipo un governo venga messo in crisi. Ci sono altri strumenti in mano alle forze politiche per poter intervenire e modificare le decisioni dell’esecutivo. Come ad esempio gli emendamenti ai decreti legge che passano al vaglio del parlamento. Se si vogliono apportare delle modifiche, basta proporle e, se si hanno i numeri, cambiare le cose. Questo dovrebbero fare le forze di maggioranza e le forze di opposizione: far valere in parlamento le proprie convinzioni, e non altrove. Non nei vertici di partito, ma nella sede deputata. Tutti i governi hanno sbagliato, ma mettiamo il caso che questo abbia sbagliato di più: a maggior ragione il parlamento dovrebbe intervenire con proposte e misure concrete. Come sul Recovery fund, su cui molto si punta per la ripartenza. Non riesco a capire la polemica che ruota attorno a questi fondi. Il governo ha proposto una bozza e delle linee guida. Non piacciono? Bene, se ne discute in parlamento e si fanno proposte. Ma lì, non negli incontri bilaterali dei partiti. Riaffermiamo la centralità delle Camere. Sarebbe un’ottima fuoriuscita da questa situazione e si ricalibrerebbero tutte le polemiche nei confronti del governo”.
Durante i mesi della pandemia, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato una lunga serie di decreti. I tanto famosi quanto discussi dpcm. Dove si pongono rispetto alla costituzione? Sono costituzionali o incostituzionali?
“Bisogna inquadrare bene la situazione. Per quanto riguarda la sicurezza della salute nazionale e la compressione dei diritti fondamentali, come quello alla circolazione, ricordo che la nostra costituzione stabilisce che questo è possibile, fatta salva la riserva di legge. Per i dpcm, emanati nel corso dei mesi, abbiamo avuto una tessitura normativa abbastanza complessa, forse anche discutibile. Il fondamento di legittimazione, oltre agli articoli della costituzione, sono stati due decreti legge. E ancor prima la dichiarazione dello stato di emergenza.
I decreti a firma del solo presidente del consiglio hanno due difetti costituzionali: non vengono vagliati dal capo dello stato perché sono atti amministrativi e non normativi, e non passano neppure al vaglio del parlamento. Sono sostanzialmente atti autoritativi del governo. Per questo devono essere contenuti ed emanati nei momenti di assoluta necessità, quando non si può attendere neppure un momento di più per intervenire.
Quello che posso dire è che la limitazione della libertà personale attraverso un atto amministrativo si pone al limite della costituzione. I dpcm non sono incostituzionali, ma sono al limite. Per questo devono essere utilizzati in caso di assoluta impossibilità di altri interventi. Quando cioè la necessità, la pandemia e il numero di morti giornalieri li impongono. Nella prima fase dell’emergenza ne sono stati fatti anche troppi, ma comunque tutti legittimati dalla situazione. Quelli successivi, invece, sono meno giustificati. E non perché non ci sia più la pandemia, ma perché sarebbe necessario e possibile optare per diverse alternative”.
Quali strumenti, dunque, avrebbe potuto mettere in campo il governo?
“Dopo la prima e più critica fase dell’emergenza, sarebbe stato opportuno passare dai decreti di responsabilità del solo presidente del consiglio a quello strumento che la nostra costituzione individua come atti di altrettanta urgenza che sono i decreti legge. Anche questi sono atti straordinari, però per lo meno, a differenza dei dpcm, vengono emanati dal capo dello stato, che è il garante della costituzione e poi sono vagliati dal parlamento. Vengono convertiti in legge entro 60 giorni dalle Camere e quindi c’è un maggiore controllo.
Quello che mi preme sottolineare però è che durante un’emergenza come quella che stiamo vivendo, è al governo che bisogna affidare il coordinamento nazionale della gestione della pandemia. Anche in questo caso la nostra costituzione dà indicazioni chiare. Come cita l’articolo 117 alla lettera q, nel rispetto assoluto del principio di autonomia, si affida al governo la profilassi nazionale. È lui che deve decidere e dettare le regole di carattere sanitario. Abbiamo assistito, invece, in questi mesi a presidenti di regione e sindaci che hanno preso decisioni autonome, contro ogni principio di collaborazione. Eppure nessuno si salva da solo. È uno slogan, certo, ma tradotto in un’affermazione più giuridica significa che c’è bisogno di una linea comune. Come ha detto il nostro presidente della repubblica Sergio Mattarella, rivolgendosi anche alle autonomie locali, in questo momento più che alle proprie competenze, che certo non debbono essere messe in discussione, bisogna pensare all’interesse nazionale”.
Lo stato decide per tutti cosa è importante e cosa non lo è. La salute viene prima e prevarica libertà essenziali, tradizioni, economia, cultura. Ma quanto si possono comprimere le libertà? Lo stato di diritto è in pericolo?
“Lo stato di diritto non è in pericolo fintanto che ci si attiene a quel testo che lo fonda e lo garantisce, che è la costituzione. Questo non può voler dire che tutti gli atti messi in essere dal governo siano giusti e costituzionalmente legittimi. Può darsi che i soggetti che hanno responsabilità politica, come il governo, il parlamento, i presidenti di regione, i sindaci in questi mesi abbiano sbagliato nel merito o abbiano compiuto degli atti illegittimi. Fintanto però che c’è uno stato di diritto e si rispetta la costituzione, questa è la nostra garanzia più grande”.
Cosa cambierà sul piano economico dopo l’onda d’urto del Covid? Chi secondo lei pagherà il prezzo più alto per la crisi?
“Già vediamo chi sta pagando il prezzo più alto: tutti i lavoratori. Abbiamo di fronte delle sfide epocali, da prendere molto sul serio per sperare in una ripartenza. Pensare di poter tornare alla situazione di ieri è una follia. Abbiamo vissuto negli ultimi 40 anni un’idea di sviluppo senza freni. Ci dobbiamo rendere conto che il tutto deve essere ripensato. Bisogna prestare più attenzione non tanto allo sviluppo quanto al progresso, come diceva Pier Paolo Pasolini. Questa è l’occasione per riequilibrare uno sviluppo distorto. Quando finiranno ristori, la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti, avremo una situazione drammatica…”.
Il Covid è una rivincita della natura sull’uomo?
“Non lo so, però è sicuramente l’espressione di un nostro cattivo rapporto con la natura. Su questo non ho alcun dubbio. Il Covid ci dovrebbe insegnare un maggiore rispetto e una maggiore attenzione nei confronti di ciò che ci circonda. Dietro l’ideologia dell’individualismo, per anni abbiamo avuto la convinzione di essere i padroni dell’universo. Ora a nostre spese impariamo che non è così. Quello che dovremo fare è cercare un nuovo equilibrio con l’ambiente”.
Cosa rimarrà nella storia? Come sarà il mondo dopo la pandemia? Il Covid può essere considerato uno spartiacque? Uno di quegli avvenimenti per cui, come guerre e grandi scoperte, si crea una netta separazione tra il “prima” e il “dopo”?
“Più va avanti l’emergenza, più realizziamo che quello che stiamo vivendo è un momento di svolta epocale per il mondo intero. Durante il duro periodo del lockdown, mi è venuto in mente un bellissimo lavoro del filosofo e giurista Giuseppe Capograssi che, dopo la fine della seconda guerra mondiale, scrisse “Il diritto dopo la catastrofe”. Lui sosteneva che l’uomo impara dalle tragedie e che le sciagure possono divenire strumenti di cambiamento. Farlo in meglio o in peggio, poi, dipende esclusivamente dagli uomini. Per questo sottolineava come la catastrofe sia una condizione necessaria, ma non sufficiente. Ho pensato molto a ciò durante i mesi più duri che abbiamo vissuto: il Covid-19 sicuramente ci porterà a un cambiamento. Muteremo lentamente. Ma dipenderà da noi scegliere in quale direzione camminare. Posso auspicare che ne usciremo migliori, non posso escludere che ne usciremo peggiori, l’unica certezza è che non ne usciremo identici, come se nulla fosse accaduto. È questa la delicatezza del momento. Sta qui la responsabilità di ciascuno di noi”.
Lei che è professore universitario, pensa che gli studenti degli atenei italiani abbiano risentito del prolungato ricorso alla didattica a distanza?
“Penso di sì. È un problema delicatissimo, a cui dovremmo dare una soluzione in tempi più brevi possibile. Sono consapevole delle necessità che in questo momento viviamo, del distanziamento sociale e della difficoltà dell’organizzazione didattica. Insegno nel più numeroso ateneo italiano, La Sapienza di Roma, vedo le criticità che possono sorgere e per questo motivo non penso che dall’oggi al domani faremo ritorno alla didattica classica. Quella a distanza è però un surrogato, una toppa che abbiamo messo con impegno, ma è pur sempre una soluzione di emergenza. L’università è una comunità di studio e di pensiero. Che non si esaurisce nell’andare a sentire le lezioni, ma significa anche vivere all’interno di una comunità. Il colloquio e il confronto con gli altri è fondamentale. Inoltre è molto più difficile far appassionare gli studenti alla materia che si insegna attraverso lo schermo nero di un pc e parlare fissando un’asettica luce verde, senza neppure vedere gli studenti in faccia”.
Quale è stata per lei la lezione del Covid?
“Ho imparato che dobbiamo razionalizzare le nostre aspettative. Essere più umani. Il Covid ci ha mostrato diverse facce: da un lato il peggio che l’umanità potesse tirar fuori, l’egoismo, la paura dell’altro come possibile contaminatore. Ma ci ha anche mostrato il meglio, l’enorme solidarietà che ci ha unito in questi terribili mesi. Ancora una volta ci torna in aiuto la costituzione dove i diritti inviolabili dell’uomo sono strettamente legati ai doveri di solidarietà sociale. Queste due dimensioni devono camminare mano per la mano. Ecco cosa auspico che abbiamo imparato”.
Barbara Bianchi
3 febbraio, 2021
Interviste Coronavirus ... Gli articoli
- Anghileri: "Gli aiuti a pioggia non hanno funzionato, 73mila imprese al momento sono chiuse"
- Vauro: "Il Covid è classista, colpisce più duramente le classi più deboli della società..."
- Franca Fossati-Bellani: “Con il virus fortemente penalizzate la diagnostica e la prevenzione di tutte le altre patologie"
- Valerio Magrelli: "Renzi, che ha fatto cadere il governo, si schieri apertamente con Meloni e Salvini"
- Carlo Cellucci: “Salvini ha fatto a gara con i negazionisti alla Trump e Bolsonaro...”
- Mario Capanna: "La pandemia è stata la prova del fuoco per la democrazia"
- Massimo Scalia: "Uno degli aspetti positivi della pandemia è aver 'sbreccolato' le politiche di austerity"
- Riccardo Valentini: "La prossima guerra sarà contro i batteri e quelli mi fanno più paura dei virus"
- Matteo Bassetti: "Chi vuole lavorare negli ospedali deve essere vaccinato, altrimenti vada a fare un altro mestiere"
- Vito Mancuso: "Per anni abbiamo rimosso la morte, il Covid ci ricorda in maniera drammatica che esiste..."
- Massimo Fornicoli: "Le teorie negazioniste sono un meccanismo di difesa patologica, come diceva Freud"
- Dino Meneghin: "Giusto il rinvio delle olimpiadi, sarebbe stato rischioso radunare atleti, dirigenti e allenatori..."
- Antonio Di Pietro: "I negazionisti? Se fossi ancora un pm, questi personaggi senza scrupoli li sbatterei in galera"
- Sara Simeoni: “Abbiamo invaso la natura per anni, la pandemia ci insegni il rispetto”
- Franco Ferrarotti: "La nostra identità si forma nel contatto con gli altri, gravissimo non poter uscire..."
- Fausto Bertinotti: "Con il Covid il governo ha accentuato la sua propensione neoautoritaria"
- Tina Montinaro: "Se lo stato non c'è, la mafia arriva, garantisce e poi chiede il conto"
- Franco Cardini: “La nostra società ormai è nella situazione di un malato cronico trascurato per decenni”
- Gino Roncaglia: “Stiamo facendo un uso emergenziale della Dad, ma c’è bisogno di più consapevolezza e di infrastrutture”
- Jury Chechi: “Palestre e piscine devono riaprire, è ora che lo sport amatoriale riprenda”
- Federica Angeli: "Vivo sotto scorta da sette anni, la mia vita era già in lockdown"
- Emma Bonino: "Da soli non si va da nessuna parte, il Covid ci ha insegnato che il nostro destino è l'Europa"
- Enrico Magrelli: “Il cinema è in crisi, ma il Covid può essere l'occasione per ripensare il futuro dello spettacolo”
- Massimo Wertmüller: "La natura oggi si riprende i suoi spazi, clima e Covid ci stanno dando una lezione..."
- Nicola Rossi: "Da 25 anni ci stiamo impoverendo, l'Italia è nuda di fronte alla pandemia"
- Antonio Ingroia: "Mafie e Covid vanno a braccetto"
- Edek Osser: "Disprezzo culturale per i negazionisti, non capisco come si possa voltare le spalle alla scienza"
- Dacia Maraini: “C’è una tendenza all’anarchia, libertà non significa non mettersi la mascherina o non vaccinarsi”
- Guido Crosetto: “La salute pubblica non può essere una scusa per distruggere la democrazia”
- Alfonso Antoniozzi: "Il Covid ha schiacciato poveri e lavoratori in nero, ignorare il problema ora non è più possibile..."
- Giorgia Meloni: "Il governo Conte è una catastrofe per l'Italia, ci sarà una nazione da ricostruire"
- Gianluca Nicoletti: "Lo stato di diritto è in pericolo quando c’è una dittatura e non con un'epidemia"
- Paolo Crepet: "Non siamo nati ergastolani, 40 milioni di italiani positivi al male di vivere..."
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY